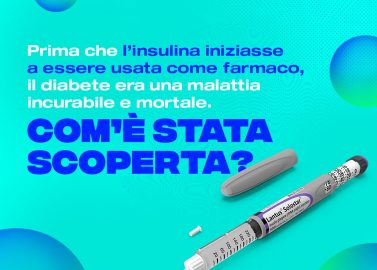Biodiversità e terapie anticancro
Molti chemioterapici sono stati scoperti in natura, sia sulla terraferma sia nei mari. I “laboratori” di chimica capaci di produrre la maggiore diversità di molecole appartengono al mondo naturale, ma la sfida è trovare più velocemente “gli aghi nei pagliai”. E, una volta trovato il composto promettente, la strada per arrivare al farmaco resta molto lunga.
Ci sono molte ragioni per proteggere la biodiversità e una delle più pragmatiche è che la natura è un laboratorio chimico che produce sostanze preziose per la vita delle persone, comprese quelle in grado di combattere i tumori. Questo non significa che il cancro si possa curare “naturalmente”, mangiando questa o quella bacca. Significa piuttosto che, nella ricerca di nuovi farmaci, si è rivelato spesso utile considerare anche le proprietà farmacologiche delle molecole già presenti in natura.
Oggi il nostro arsenale di farmaci contro i tumori deriva in buona parte (almeno il 60 per cento) da prodotti naturali. Soprattutto piante, ma anche microrganismi e organismi marini. Questo non dovrebbe stupirci troppo, dal momento che c’è un legame storico tra farmacologia e sostanze naturali. Basta pensare all’acido acetilsalicilico, il principio attivo dell’aspirina: si tratta della versione sintetica, e più efficace, dell’acido salicilico, un composto isolato dalla corteccia del salice. Per fare un altro esempio, il chinino è uno dei più noti farmaci antimalarici ed è stato isolato dall’albero della china. Ma come si fa a scoprire che una sostanza può essere utile a sconfiggere, per esempio, un tumore, nell’immenso numero di organismi che abitano il pianeta? A volte può capitare un colpo di fortuna.
Il segreto della pervinca del Madagascar
Negli anni Cinquanta, per esempio, il medico canadese Clark Noble stava studiando la pervinca del Madagascar (Catharanthus roseus), una pianta endemica del paese africano, ma diffusa anche nella fascia tropicale e sub-tropicale. Secondo la medicina popolare dell’epoca, dalle sue foglie si poteva ricavare un tè che aiutava i pazienti diabetici. Noble voleva capire se fosse vero e, nel caso, quale fosse il principio attivo.
Le foglie di Catharanthus non avevano alcun effetto antidiabetico nelle cavie, ma Noble notò che facevano diminuire i globuli bianchi. Il medico provò a somministrarle a topi malati di leucemia, un tumore in cui i globuli bianchi si moltiplicano in modo incontrollato, e notò che la sopravvivenza degli animali si prolungava. Alla fine gli scienziati riuscirono a isolare dalla pianta i due alcaloidi responsabili, chiamati vincristina e vinblastina, che inibiscono la divisione di tutte le cellule che si moltiplicano rapidamente, incluse quelle tumorali. I test negli esseri umani infine stabilirono che questi alcaloidi potevano essere usati contro diversi tipi di linfomi e leucemie, ma anche per il trattamento dei tumori cerebrali e del tumore polmonare a piccole cellule. Queste sostanze sono tuttora impiegate nelle terapie.
La storia del taxolo
Non ci si può certo, però, affidarsi solo alla fortuna. Così, a partire dal secondo dopoguerra, la ricerca di sostanze utili in natura, antineoplastici inclusi, è stata improntata sulla ricerca sistematica di campioni biologici, detta in gergo bioprospezione. I campioni prelevati in natura vengono conservati e analizzati, cercandovi soprattutto classi di molecole note per avere un’attività biologica.
È in questo modo che si è scoperto il taxolo, uno dei più noti chemioterapici. Nel 1962 ricercatori del Dipartimento dell’agricoltura statunitense avevano raccolto dei campioni di corteccia di tasso del Pacifico (Taxus brevifolia) nell’ambito di un programma di bioprospezione del National Cancer Institute. Un paio di anni dopo i chimici Monroe Wall e Mansukh Wani, assieme ai loro colleghi del Natural Products Laboratory presso il Research Triangle Institute in Carolina del Nord, scoprirono in laboratorio che gli estratti della pianta avevano un’attività citotossica su cellule cancerose come quelle del sarcoma di Kaposi, cioè erano in grado di uccidere selettivamente le cellule tumorali. Ci vollero altri anni di ricerca, ma alla fine riuscirono a isolare un promettente principio attivo (che, si scoprì, era presente anche in altre specie di Taxus), e cominciarono i test sugli animali, che confermarono i risultati in merito all’attività antitumorale.
I primi test negli esseri umani, effettuati in molti gruppi di pazienti affetti da tipi di cancro diversi, cominciarono nel 1984 e nel 1992 il farmaco venne approvato per l’uso. Inizialmente l’utilizzo fu autorizzato contro il cancro alle ovaie, ma in seguito il taxolo si dimostrò efficace anche contro il cancro al seno. Il farmaco, è bene ricordarlo, non è costituito dal solo principio attivo, ma anche dalle sostanze eccipienti che facilitano la sua azione. Nel caso del taxolo, c’è voluto molto lavoro per capire con quali eccipienti fosse meglio iniettarlo.
Sempre negli anni Sessanta, i protagonisti di questa storia trovarono in maniera analoga un altro principio attivo chemioterapico, la camptotecina, isolata dalla pianta Camptotheca acuminata, endemica della Cina.
Proteggere la biodiversità non basta
Anche se dà i suoi frutti, l’isolamento di composti utili a partire dall’analisi di centinaia di migliaia di campioni di sostanze naturali richiede un’enorme quantità di tempo, lavoro e fondi. Esistono però metodi per accelerare queste scoperte. Per esempio, grazie a tecniche per il sequenziamento del genoma sempre più economiche, possiamo leggere il DNA delle specie campionate e prevedere quali potrebbero produrre sostanze interessanti.
Un’altra strategia, del tutto complementare, è farsi guidare dalla etnofarmacologia, cioè lo studio delle piante che vengono già usate tradizionalmente dai popoli indigeni. Come accaduto nel caso del chinino, dell’acido salicilico e di molti altri composti, è possibile che queste piante abbiano effettivamente un’efficacia farmacologica, e quindi dei principi attivi da studiare.
Visto che non conosciamo ancora tutte le specie del pianeta, ed è opinione condivisa dagli ecologi che se ne estinguano di più rispetto a quelle che scopriamo, la distruzione degli habitat è un danno anche per la messa a punto di nuovi farmaci. Rischiamo cioè di perdere, assieme alle specie, anche le molecole che ci sarebbero utili.
Inoltre la bioprospezione è accompagnata da altri tipi di problemi. Per esempio, la scoperta di una specie utile per la produzione di un farmaco può portare a uno sfruttamento insostenibile della risorsa naturale. Soprattutto quando il principio attivo non può essere riprodotto per sintesi chimica, o ciò non può avvenire rapidamente, la produzione dipende in tutto o in parte dalla raccolta del composto in natura, e ciò può diventare una minaccia per la sopravvivenza della specie.
La bioprospezione rischia poi, in alcuni casi, di scivolare in ciò che alcuni chiamano biopirateria, ovvero lo sfruttamento, da parte degli scienziati di un determinato Paese, delle risorse naturali di un altro Paese ricco di biodiversità, magari anche usando come guida le conoscenze degli indigeni. Una volta che un farmaco di questo tipo è brevettato e commercializzato, i proventi non tornano alle comunità locali dei territori dove il principio attivo è stato identificato e isolato.
Al momento il trattato internazionale di riferimento per evitare casi di biopirateria è il protocollo di Nagoya, entrato in vigore nel 2014. Il trattato prevede una serie di procedure che mirano a tutelare lo sfruttamento delle risorse genetiche e a garantire la condivisione dei benefici.
Tuttavia, non tutti i Paesi hanno preso finora le misure necessarie per rendere efficace il protocollo. Per esempio, a febbraio 2020 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, che non aveva ancora stabilito le sanzioni per il mancato rispetto del regolamento europeo che attua il protocollo di Nagoya. L’Italia ha emesso un decreto legislativo in merito solo lo scorso dicembre.